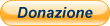Il metodo Montessori
“Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l’umanità.”
Maria Montessori
Principali aspetti del metodo
L’idea alla base del metodo rivoluzionario di Maria Montessori è che il bambino vada lasciato libero di esplorare il suo mondo, con la certezza che ci sia un impulso imperscrutabile in lui che lo spinge verso l’apprendimento. In questo senso, la curiosità del bambino è il vero motore dell’apprendimento che, se lasciato “girare” senza interferenze, porterà il bambino a sviluppare al massimo tutto lo spettro delle proprie capacità e a conquistare il mondo con la forza della sua intelligenza.
E’ necessario intervenire intenzionalmente sulla predisposizione e strutturazione dell’ambiente educativo che deve essere scientificamente organizzato e preparato ad accogliere i bambini, sulla scelta e utilizzazione del materiale di sviluppo, sulla ridefinizione del ruolo e della funzione dell’educatore.
E’ l’ambiente, quindi, il primo elemento a rivestire per la Montessori un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei bimbi.
La “casa dei bambini”, così viene definita la scuola dalla Montessori, perché simile all’ambiente di vita naturale del bambino, deve essere organizzata in modo tale da suscitare interesse nei bambini e venire incontro al desiderio e al bisogno di movimento, di scoperta e di esplorazione autonoma dei bambini. Questi cioè debbono avere la possibilità di venire direttamente in possesso degli oggetti e dei materiali di cui, in quel particolare momento, sentono il bisogno, prelevandoli da tavoli, da armadi, da scaffali che siano “alla loro portata” e che non li costringano a ricorrere all’aiuto dell’educatore.
Qui il bambino non incontra più ostacoli di ordine strutturale che possano in qualche modo inibire il suo naturale sviluppo senza essere vincolato alla disponibilità e ai voleri, spesso estemporanei e casuali, dell’insegnante.
Gli arredi devono essere pensati e studiati tenendo conto dell’età e della corporatura dei piccoli, costruiti all’insegna della leggerezza in modo che, proprio a causa della loro fragilità, rivelino un utilizzo sbagliato o mancanza di rispetto da parte di coloro che ne fanno regolarmente uso (per questo motivo, nelle scuole montessoriane vengono utilizzati piatti di ceramica, bicchieri di vetro, soprammobili fragili: i bambini sono, in questo modo, invitati a coordinare i movimenti con esercizi quotidiani di autocontrollo, autocorrezione e prudenza).
L’organizzazione dell’ambiente accompagna il bambino ad acquistare coscienza delle proprie capacità, a scoprire via via l’uso delle sue mani (la mano per la Montessori è l’organo dell’intelligenza), a rassicurare la deambulazione, a diventare perciò sempre più indipendente.
I campi di interesse sono rivolti principalmente alle “attività di vita pratica” legate alla cura della persona e alla cura dell’ambiente: lavarsi, vestirsi, allacciare, spolverare, travasare, stirare, lavare, sbucciare, spremere, trasportare, apparecchiare… il bambino perfeziona l’esperienza sensoriale facendo “ordine” nelle proprie scoperte, usando i materiali predisposti a questo scopo. Egli può scegliere liberamente le attività che sono sempre a sua disposizione, collocate alla sua altezza e che dovrà riordinare dopo l’uso.
Il bambino vuole fare da solo, perciò le attività sono individuali e rispettano tempi, modalità e ritmi di ciascuno. Durante la giornata ci sono anche momenti di gruppo: quando si pranza, quando si cantano canzoncine o si ascolta un racconto della maestra o si chiacchera insieme, quando si gioca in giardino o in palestra e quando, stanchi, si va tutti a nanna!
I bambini, piccoli o grandi, hanno libertà di scelta delle attività in un ambiente sempre accuratamente preparato e imparano ad assumersi le responsabilità del riordino degli oggetti usati e il rispetto per il lavoro dei compagni. La libertà ha confini precisi, chiari e uguali per tutti. Ogni bambino viene trattato con riguardo: a nessuno sono consentite la sopraffazione o la violenza. Rispetto è anche non interrompere il lavoro di un altro, non toglierlo dalle mani, non sciuparlo.
Rispetto è non giudicare, non imporre ed è soprattutto dall’atteggiamento degli adulti verso di lui che il bambino assorbe un comportamento sociale accettabile.
Il bambino è invitato a mantenere l’ordine dell’ambiente, a non sciupare il lavoro del compagno, a rispettare le scelte e i ritmi degli altri, perchè interiorizzi a poco a poco che la libertà ha confini precisi, e deve avere come limite I’interesse collettivo.
Nel metodo montessoriano l’educatore assume una funzione di gran lunga più alta di quella tradizionale. All’insegnante che controlla, dirige, condiziona pesantemente i tempi, i ritmi e i desideri di apprendimento del bambino, ricorrendo con estrema facilità e naturalezza all’arma dei premi e dei castighi, la Montessori oppone un docente che svolge con estrema competenza un ruolo di mediazione tra il bambino e l’ambiente educativo, aiutandolo, sostenendolo e consigliandolo, ma mai imponendosi e sostituendosi a lui. L’educatore quindi ha il compito importante di preparare l’ambiente e successivamente di presentare il materiale che verrà messo a disposizione dei bambini.
Se dunque il ruolo di protagonista, in questa rinnovata organizzazione scolastica, spetta al bambino, l’insegnante non è tuttavia una figura “assente”: pur rispettando e adeguandosi, nel suo progetto formativo, a quello che è l’autonomo itinerario di sviluppo evolutivo del bambino, suo compito qualificante e impegnativo è quello di seguire seriamente e scientificamente il dispiegarsi dello sviluppo infantile.
Educare, per ogni maestra montessoriana, deve significare aiutare i bambini a divenire consapevoli del dono che già possiedono e a svilupparlo durante il corso della loro vita. L’educazione è un’educazione per la vita: è il diventare consapevoli di noi stessi, del posto che occupiamo fra tutte le cose che ci circondano, nella società e nell’universo intero.
L’intervento educativo della maestra, dunque, è tutt’altro che diretto: è più passivo che attivo; è un orientamento tra diverse possibilità; è una figura sempre pronta a fungere da ascoltatore, da osservatore e da stimolo discreto. L’educatore deve saper cogliere il giusto momento per intervenire con pazienza e umiltà senza sostituirsi al bambino (compito molto difficile per gli adulti, genitori ed educatori, che si sostituiscono sempre quando il bambino non riesce in qualcosa). La maestra non insegna al bambino la sua verità, non cerca di travasare in lui la il suo sapere ma dirige (viene, infatti, chiamata direttrice ) le attività del bambino, quella attività che gli permettono di sviluppare il suo spirito in modo libero di liberare le sue immense energie, e potenzialità che la società e la scuola tradizionale invece comprimono implacabilmente.
All’interno della didattica montessoriana assume un ruolo fondamentale il materiale di sviluppo.Il grande lavoro e l’impegno che Maria Montessori ha dedicato alla creazione del materiale di sviluppo, è facilmente comprensibile se si coglie l’elevato scopo che il materiale riveste: esso, infatti, attraverso l’educazione dei sensi, “fornisce una solida base allo sviluppo dell’intelligenza” e costituisce per il bambino una “esatta guida scientifica” per la sua attività di organizzazione e classificazione dei contenuti di esperienza.
Per concludere “Aiutami a fare da me!” è un aforisma che riassume l’intero metodo di Maria Montessori.
“AIUTAMI”
È la richiesta di aiuto che ogni bambino rivolge agli adulti o ai più grandi. Vuol dire “ho bisogno di te”, perché da soli non si può vivere, né tanto meno ci si può educare.
“A FARE”
Se faccio, capisco. Nessuno può apprendere al mio posto, nessuno può essere libero, autonomo, intelligente al mio posto.
“DA SOLO”
Il vero fine dell’educazione è il bambino, l’adulto è al suo fianco. Apprendere è un verbo attivo, ogni aiuto inutile è un ostacolo allo sviluppo.
Le osservazioni di Maria Montessori, così attente, acute e prolungate nel tempo, hanno messo in luce come il bambino, fin dalla nascita, attivi naturalmente e spontaneamente un processo di sviluppo che si manifesta secondo percorsi graduali e differenti per ognuno nei tempi e nei modi.
“Aiutami a fare da solo”: è l’esortazione che ogni bambino espone silenziosamente agli adulti, da sempre. Richiama gli educatori a non interferire con impazienza nello sviluppo dei bambini, a non sovrapporre la nostra domanda al loro personale percorso maturativo ma a fornire ai bambini gli aiuti opportuni, nei tempi opportuni, come risposta ai continui e differenti bisogni: i bambini imparano da soli. Un impulso vitale naturale spinge infatti il bambino ad agire per conoscere ed apprendere attraverso la personale esperienza.
Fonte: http://www.educatoridigitali.it/2012/09/19/ecco-cose-il-metodo-educativo-montessori
La mente assorbente
In "La mente del bambino" Maria Montessori afferma che “la parte più importante della vita è quella che corrisponde […] al primo periodo, che si estende dalla nascita ai sei anni”[1].
La mente del bambino tra i 0 e i 6 anni è molto diversa da quella dell’adulto. Montessori la definisce una mente assorbente, in quanto possiede lo straordinario potere di assorbire in maniera inconscia gli elementi presenti nell’ambiente di vita del bambino. Essa consente a quest’ultimo di “incarnare”, cioè di assimilare, le impressioni dell’ambiente (modalità di comportamento, norme e lingue), e tutto ciò avviene senza che il bambino vi partecipi col suo sforzo, ma solo “vivendo”, cioè attraverso le sue esperienze.
Egli lo fa senza averne coscienza, senza averne volontà: impara, ma non perché abbia coscientemente deciso “voglio imparare”. Il bambino riesce a fissare le impressioni che riceve dall’ambiente nella sua psiche proprio come avviene per una pellicola fotografica a contatto con la luce.
La prima infanzia quindi è considerata da Montessori una vera e propria età dell’oro, il periodo della creazione delle basi del carattere, dell’intelletto e della personalità.
Il bambino dunque non è qualcosa di predefinito o di preformato, ma si costruisce da sé. Ciò che assorbe viene fissato per sempre nella sua personalità e lo influenza per tutta la vita (gli studi di Sigmund Freud hanno dimostrato infatti che gli avvenimenti della prima infanzia condizionano tutta la successiva esistenza).
Il fatto che la mente infantile abbia la capacità di assorbire attraverso il proprio vissuto le impressioni che egli riceve dall’ambiente non significa però che il bambino sia un essere passivo. Egli assimila non tanto ciò che viene passivamente incontrato, quanto ciò con cui si relaziona attivamente attraverso la propria attività spontanea. La mente assorbente è infatti “creatrice” il che significa che il bambino è un soggetto psichicamente attivo, che interagisce con il proprio ambiente circostante e che attraverso l’esperienza e la vita stessa raggiunge anche gli apprendimenti più complessi (come il linguaggio) e realizza se stesso.
La mente assorbente consente il realizzarsi di un fenomeno che Montessori, con una bellissima espressione, definisce “chimica mentale”[2]: è come se tra ambiente e bambino si venisse a creare una reazione chimica, che fa in modo che le impressioni del primo si incarnino nella mente del secondo, la formino e la trasformino, al punto che egli finisce per assomigliare a ciò che lo circonda: “I bambini diventano come la cosa che amano”[3]. Ed è per questo che il bambino, mentre conosce il mondo, crea se stesso, crea la sua carne mentale, gli strumenti cognitivi e comunicativi che lo renderanno un adulto consapevole.
Quella del bambino è quindi una mente privilegiata, diversa da quella dell’adulto. Non le appartiene il pensiero logico, la razionalità, la memoria cosciente. E’ una mente inconscia, non razionale, assimilatrice e onnivora, in quanto essendo ancora incapace di selezionare gli elementi intorno a sé si impregna di tutto ciò che il suo ambiente le comunica.
Questo non significa che la mente del bambino sia inferiore rispetto a quella dell’adulto (come spesso si è portati a credere): essa è semplicemente diversa. Anzi, per certi versi essa può essere considerata migliore. Montessori fa diversi esempi circa come la vita potrebbe essere assai più semplice per l’adulto se questi potesse apprendere semplicemente vivendo, in maniera leggera ed entusiasta come un bambino, piuttosto che attraverso lo sforzo e un notevole impegno.
Nell’adulto infatti l’apprendimento avviene attraverso un atto di volontà cosciente e richiede attenzione, applicazione e sacrificio. L’adulto è quindi guidato dal pensiero logico-razionale mentre per il bambino l’apprendimento è una creazione naturale. Egli impara vivendo, sperimentando il mondo, nella sua mente non esiste separazione tra contenitore e contenuto, cosa che invece avviene negli adulti.
L’adulto non è ancora capace di comprendere tout court che il bambino sin dalla nascita porta con sé delle sue potenzialità, dei suoi poteri psichici. E’ invece importante che egli ne sia pienamente consapevole e che sfrutti tale consapevolezza per sostenere il bambino.
Questo straordinario potere (confermato anche dalle moderne neuroscienze) non è infatti eterno: presente dalla nascita, vede il suo culmine intorno ai tre anni, per poi gradualmente scemare fino ai sei anni, quando il bambino accede al pensiero logico e razionale, e a quel punto “ogni nuova acquisizione di sapere ci è causa di duro lavoro e di fatica”[4].
Nella coscienza collettiva manca invece tuttora la consapevolezza della vera importanza della prima infanzia. Manca il ricordo di quella fase della vita in cui avevamo la capacità di imparare senza bisogno di maestre, senza doverci mettere a studiare e andare a scuola, quando apprendevamo semplicemente vivendo. Una fase che oggi ci sembra irreale, una bella fiaba, ma che invece nei nostri primi anni di vita ha rappresentato il modo in cui abbiamo creato noi stessi, grazie alla meravigliosa ed irripetibile forza creativa della mente assorbente.
Essa è un vero e proprio dono dell’umanità nonché prova della necessità di un’educazione fin dalla nascita. L’approccio educativo indicato da Maria Montessori e suggerito dal bambino stesso a chi sa accoglierlo e restare in ascolto dovrà esser dunque volto ad “aiutare la mente nei suoi diversi processi di sviluppo, secondarne le varie energie e rafforzarne le diverse facoltà”[5].
[1] MONTESSORI M., La mente del bambino, Milano, Garzanti, 1999, pag. 22.
[2] MONTESSORI M., La mente del bambino, Milano, Garzanti, 1999, pag. 25.
[3] MONTESSORI M., La mente del bambino, Milano, Garzanti, 1999, pag. 105.
[4] MONTESSORI M., La mente del bambino, Milano, Garzanti, 1999, pag. 26.
[5] MONTESSORI M., La mente del bambino, Milano, Garzanti, 1999, pag. 29.
Fonte: http://www.aiutamiafaredame.it/la-mente-del-bambino-mente-assorbente
Riferimenti esterni
-
Domande frequenti sul metodo Montessori, mariovalle.name/montessori/faq.html#faq09
-
Fondazione Montessori Italia, fondazionemontessori.it
-
Opera Nazionale Montessori, montessori.it
-
Fondazione Chiaravalle Montessori, montessoridesign.it
-
(EN) e-text del Metodo Montessori di Maria Montessori, digital.library.upenn.edu
-
(EN) AMI - Association Montessori Internationale, montessori-ami.org
-
Associazione Montessori Marche, associazionemontessori.it
-
Maria Montessori dietro Google, Amazon e Wikipedia? (articolo)
Principali differenze tra metodo Montessori e metodo tradizionale
M:Montessori T:Tradizionale
M: L’educazione si fonda sul profondo rispetto per i bambini intesi come esseri unici ed irripetibili e si intende come aiuto al naturale sviluppo dell’essere umano.
T:L’educazione si identifica con un programma curricolare nazionale applicato ad un gruppo di bambini che devono uniformarsi allo stesso standard.
M:I bambini non sono tutti uguali: ci sono modi e tempi diversi di imparare, attitudini differenziate. L’approccio Montessori è studiato in funzione del rispetto di queste diversità, rispondendo alle caratteristiche di ciascuno.
T:I bambini vengono considerati tutti uguali: devono imparare secondo modalità e ritmi uniformi, flessibilià scarsa o nulla
M:L’insegnante lavora in collaborazione con i bambini sfruttando la ricchezza degli spunti individuali.
T:Il lavoro è condotto dall’insegnante che non può assecondare spunti individuali se non per brevissimo tempo.
M:I bambini deducono contenuti, regole e significati dall’esperienza diretta con il Materiale Montessori.
T:I bambini ricevono contenuti regole e significati dall’insegnante.
M:I bambini si muovono scegliendo liberamente dove stare, apprendono attraverso il movimento delle mani utilizzando il Materiale Montessori. Movimento e apprendimento sono interdipendenti.
T:I bambini stanno seduti ai loro banchi con posti fissi e imparano osservando la lavagna, lavorando esclusivamente con schede prestampate o sui quaderni.
M:L’autostima di ciascuno si costruisce attraverso la consapevolezza del proprio perfezionamento. I bambini desiderano migliorarsi spinti dalla motivazione personale.
T:L’autostima è costruita attraverso un sistema basato sulla valutazione dell’insegnante. I bambini sono spinti a competere l’uno contro l’altro per meritarsi il miglior voto.
M:Gruppi di lavoro di età eterogenea: i bambini possono lavorare individualmente o costituire autonomamente un piccolo gruppo per mettere in atto progetti creativi, e personalizzati.
T:Classi di età omogenea: il lavoro, organizzato nei modi e gestito nei tempi dall’insegnante, non consente ai bambini alcuna libertà di sperimentare soluzioni e processi creativi individuali. I lavori di gruppo sono guidati.
M:I bambini imparano moltissimo e con grande facilità, appropriandosi di efficaci strumenti operativi personalizzati.
T:I bambini imparano meno e spesso con fatica, hanno possibilità ridotte di sperimentare strumenti operativi personalizzati.
M:Gli errori servono per imparare: i bambini si correggono attraverso il Materiale Montessori, quindi non si scoraggiano e si cimentano con determinazione, energia ed entusiasmo.
T:Gli errori vengono segnalati dall’insegnante, penalizzano la valutazione e spesso i bambini si scoraggiano, frenati dalla paura di sbagliare.
M:I bambini maturano un alto grado di autodisciplina.
T:La disciplina è legata al controllo degli insegnanti.
M:Le Scuole Montessori sono molto accoglienti e rassicuranti per la comunità degli studenti, degli insegnanti e dei genitori. Nessuno si sente mai smarrito nella folla!
T:Spesso le scuole trasmettono senso di smarrimento ed estraniazione, o sono troppo silenziose e incutono timore o sono caotiche, rumorose e frastornanti.
Fonte: http://www.scuolamontessorimilano.it/differenze-tra-scuola-montessori-e-scuola-tradizionale